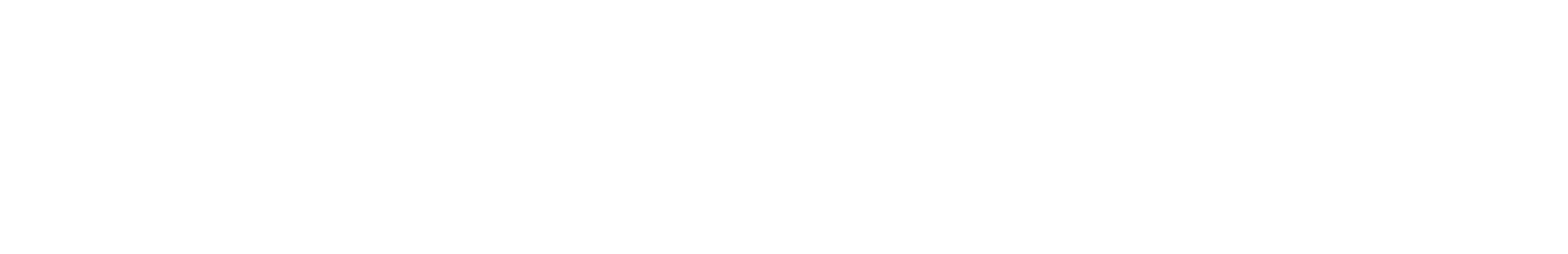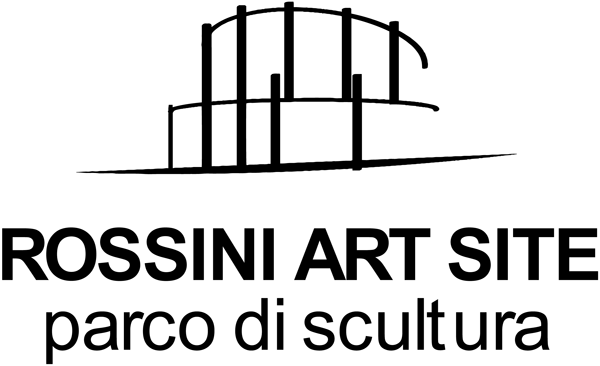Un piccolo, ma molto significativo, nucleo di opere esposte all’interno del Rossini Art Site è costituito dalle sculture di quegli autori che, per primi in Italia, intrapresero la rivoluzione dell’astrazione in scultura. Artisti come Mario Negri, Umberto Milani, Andrea Cascella, Francesco Somaini, Giò Pomodoro, Quinto Ghermandi che dall’immediato dopoguerra alla metà degli anni Sessanta ruppero la tradizione della figurazione per avvicinarsi alle ricerche che i pionieri dell’astrattismo stavano portando avanti in pittura già a partire dagli anni ‘10.
“Gli scultori italiani portano alle estreme conseguenze il rapporto tra forma e materia, e se l’idea dello scultore è rappresentata dal “dare forma” alla materia bruta, quegli scultori cominciano a valutare la materia come un elemento attivo, e non passivo, della creazione plastica. La materia, cioè, ha delle caratteristiche intrinseche che condizionano la forma. La materia stessa diventa dunque protagonista e non strumento, soggetto della scultura e non semplice mezzo.”
Il cuore della Collezione Rossini è certamente rappresentato dai rivoluzionari protagonisti del panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento.
Il Movimento Arte Concreta, l’Informale e, più in generale, quello che viene definito Astrattismo Europeo furono certamente le correnti più seguite e amate da Alberto Rossini, che, oltre a raccogliere una collezione veramente significativa di opere di questi movimenti, divenne amico e mecenate di molti dei protagonisti.
Pur appartenendo a gruppi artistici diversi e rifacendosi a ricerche estetiche parzialmente differenti, Turcato, Consagra, Leoncillo, Munari, Melotti ed alcuni altri, dettarono le regole di un nuovo modo di fare scultura, scevro di simbolismi o riferimenti psicologici, ma generato dalle impressioni che le forme, la materia e i colori della realtà imprimono sugli artisti e sugli equilibri che ne possono nascere. Di questi maestri, sono presenti nel parco alcune rare opere su larga scala, dal valore storico e poetico inestimabile; ognuna giunta in questo luogo tramite vicende che legano la storia dell’arte, a quella dell’industria e della committenza privata.
Un punto nevralgico del Parco di Scultura è la “Galleria” dedicata al Nouveau Réalisme. Con questo termine si fa riferimento a quella corrente che si diffuse agli inizi degli anni ‘60 sotto l’egida del critico d’arte Pierre Restany, amico di Alberto Rossini e frequentatore della sua casa.
All’interno di questo gruppo compatto ogni membro sviluppò un vocabolario in contrapposizione con i risvolti lirici e psicologici che l’arte astratta, materica e gestuale aveva ormai assunto. I Nouveaux Réalistes estrapolarono oggetti banali dal loro contesto quotidiano e spinsero lo spettatore a riscoprire oggetti che, altrimenti, andrebbero persi nel flusso quotidiano di stimoli visivi.
Spoerri dà vita a nuovi personaggi combinando oggetti incongruenti. Arman si serve della tecnica delle “accumulazioni” per creare composizioni di oggetti legati alla quotidianità. César comprime automobili. simboli della produzione seriale, mentre Tinguely progetta i poetici macchinari “inutili”.
L’azienda di meccanica e plastica della famiglia Rossini individuò nell’arte uno strumento efficace per la sperimentazione e l’innovazione tecnologica. Venne messo in atto un progetto coerente, in cui il mecenatismo non fu una semplice attività passiva, bensì un atto compiuto.
Oltre al sostegno economico per la realizzazione di importanti opere, l’investimento in arte si pone anche come vera e propria realtà produttiva. Parecchi artisti amici di Alberto Rossini sono stati invitati nel corso degli anni a realizzare le proprie opere con la strumentazione e le competenze dell’azienda. Ne è particolare esempio il ciclo di lavori di Erik Dietman, partito da un piccolo orsetto in legno e sfociato nelle possenti opere di ferro o ghisa. Ricordiamo anche il “Lamp Dog” di Dennis Oppenheim, oltre alla collaborazione con l’architetto Massimiliano Fuksas, affiancato nella realizzazione della maquette per la “Casa della Pace”, esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia del 2000 con lo scopo di rappresentare in scala ridotta l’edificio Peres Peace House, successivamente realizzato a Tel Aviv.
Fra i ritagli del suo lavoro, Alberto Rossini dedicava gran parte del tempo libero alla passione dell’arte e questo si traduceva in stretti legami con gli artisti che divenivano vere e proprie amicizie. Questo interscambio ha dato alla luce grandi progetti e opere monumentali come il “Demiurgo” di Andrea Cascella o la “Porta del Cremlino” di Pietro Consagra, trasposizioni in larga scala di opere più piccole. Con lo stesso entusiasmo verso l’arte e la persona, Rossini collaborò con César nella realizzazione dello straordinario ciclo di compressioni della “Suite Milanaise” del 1998 e supportò qualche anno dopo Hidetoshi Nagasawa nella fabbricazione dei grandi lavori in marmo.
Questo sostegno non si limitava ai grandi maestri, ma anche ad artisti più giovani in via di affermazione. Attraverso la residenza d’artista, costoro venivano messi nella condizione di portare a compimento progetti ambiziosi come ad esempio “la Segreta” di Antonio Ievolella o i “Tulipani” e la “Anfore” di Franz Stähler. Anche dalla grande assonanza e amicizia con l’architetto James Wines di New York, si è sviluppato e concepito il Pavillion, in memoria dello scomparso figlio Pietro, architettura ambientale perfettamente incastonata nella natura, come elemento centrale e caratterizzante di tutta la collezione.
Attraverso il resto della famiglia e il percorso di passione nell’arte non si esaurisce di certo, ma si esplica attraverso la Fondazione Pietro e Alberto Rossini producendo performance e installazioni Site-specific, il cui tratto distintivo è la ricerca estetica più attuale
In un dialogo rispettoso verso la collezione più istituzionale, artisti contemporanei, vengono invitati a produrre lavori di sperimentazione tra installazioni performative, video, interventi sonori o qualsiasi altro mezzo possibile. Tra questi hanno già trovato posto Chiara Mu, Cesare Viel, Leone Contini e Elena Bellantoni.